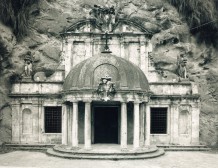|
Le Signorie
La lunga lotta con Fermo causò il disperdersi delle migliori energie
della città e contribuì alla crisi della democrazia e del regime comunale
dando cosi sempre più spazio ai pericolosi tentativi di instaurazione di
dispotiche Signorie alle quali però il popolo reagì sempre in maniera molto
determinata.
Storicamente la prima famiglia che detenne il potere dal 1318 al 1319 fu
la Dalmonte, più duraturo risultò invece il dominio della città da parte di
Galeotto Malatesta che, forte anche del fatto che aveva affidato il comando
della guerra contro Fermo, vi regnò da despota dal 1349 al 1356; altro tiranno
di questi tempi fu il Tibaldeschi ma per un breve periodo.
Dopo la pace con Urbano VI Ascoli tornò sotto la Santa Sede nel 1378 e
vi restò, seppur con ripetute lotte interne, per diversi decenni sino alla
venuta di Francesco Sforza che assoggettò la città e la governò all’incirca
per tre decenni. Di questo periodo è la nascita del primo e più antico Monte
di Pietà d’Italia ad opera del Beato Domenico da Leonessa.
Gli ascolani riescono a liberarsi degli Sforza grazie ai guelfi Dal
Monte, Sgariglia e Saladini che riottengono l’ordinamento repubblicano fatta
salva la sovranità pontificia e la dipendenza dalla Chiesa. In questo periodo
di confusione e lotte tra guelfi e ghibellini salgono alla ribalta i Guiderocchi
che però una sollevazione popolare costringe all’esilio dopo breve tempo; ai
Guiderocchi seguono i Malaspina che però nulla cambiano nel modo di gestire il
potere.
Seguono anni di buio dove non v’è limite allo scempio e dove il
banditismo regna sovrano ed Ascoli vive uno dei periodi più tristi della sua
storia civile ed il papa Pio IV toglie alla città la giurisdizione di alcuni
castelli e fa erigere in città la Fortezza Pia contro i nemici sia interni che
esterni.
Alla fine del XVI secolo la città conosce finalmente un nuovo periodo di
pace ed una ripresa dell’attività civile e rurale rappresentata anche dalla
nascita di una nuova figura sociale che è il popolano ossia un lavoratore che
per vitto e alloggio lavora alle dipendenze del proprio padrone.
Napoleone
Alla fine del XVIII secolo anche in Ascoli arrivano gli echi della
rivoluzione francese e gli ideali di libertà, uguaglianza e fraternità si
fanno largo anche nella popolazione locale tant’è che nel 1799 all’arrivo
dei soldati franco-cisalpini i repubblicani li accolsero con grande entusiasmo
ma subito dopo le attese andarono deluse, iniziarono difatti razzie e
depredamenti di chiese e conventi. Tale situazione generò una violenta reazione
popolare simbolo della quale fu Giuseppe Costantini detto Sciabolone che si
distinse per l’indomito coraggio ed lo spiccato senso strategico ma anche lui
fu alla fine battuto e costretto alla fuga dalle truppe francesi.
Nel 1808 Napoleone fa di Ascoli, Fermo e Camerino una sola provincia e la
città diventa cosi la parte più meridionale del Regno d’Italia subordinata a
Fermo; dopo alcuni anni però, alla caduta di Napoleone, ci saranno grosse
manifestazioni di gioia per la restaurazione del governo pontificio che avverrà
senza spargimenti di sangue o vendette trasversali.
|